I 4 passi per una Pedagogia dell’emancipazione rappresentano un repertorio di prassi fattibili, sono pratiche di “materialismo pedagogico” che ogni docente MCE può far proprie e proporre come leva di cambiamento nella propria realtà scolastica e da cui partire per far crescere la condivisione sulle finalità dell’educazione.
Gli interventi/azioni che proponiamo possono gradualmente incidere sui soggetti (alunni e insegnanti) e sul contest (organizzazione), modificando sfondo e relazioni, poiché occorre essere consapevoli che non ci può essere emancipazione se tra soggetto e contesto non c’è ricerca di risonanze attraverso cui il soggetto possa riconoscersi. Solo se ciò accade è possibile che si attivi una trasformazione del sé e dell’ambiente educativo.
Riteniamo che questa sia la dimensione che connota un uso politico della professionalità docente in risposta ad una scuola del conformismo e della subalternità.
Una scuola della subalternità, lontano dal farsi garante del dettato costituzionale, è una scuola della didattica trasmissiva, di una concezione impiegatizia del lavoro dell’insegnante, con la conseguente svalorizzazione del ruolo sociale degli insegnanti e del sistema scolastico.
Un uso politico della professionalità docente significa operare in ogni momento del fare scuola scelte consapevoli, che a scuola non sono mai neutre: la disposizione dei banchi, l’uso della cattedra, la tipologia di lezione, i tempi, i materiali, il valore dato ai bisogni e alle proposte dei bambini e delle bambine, delle culture e dei linguaggi di cui sono portatori, il valore assegnato alla relazione tra bambini e tra bambini e adulti.
Referente: Marco Pollano
e-mail: democrazia@mce-fimem.it
Perché proponiamo l’assemblea di classe o consiglio di cooperazione come prima tecnica per introdurre a scuola principi di democrazia?
La Scuola non è solo un’istituzione della democrazia moderna, intesa come rifiuto di tutte le separazioni arbitrarie tra eletti/degni e ignoranti/assoggettati, come “insurrezione contro tutti i privilegi”. La Scuola è anche la condizione della sua possibilità. Non è possibile nessuna democrazia senza il lungo e paziente apprendimento della costruzione di un bene comune che trascende gli interessi individuali, e quindi nessuna democrazia senza pedagogia.
Ma la pedagogia non agisce nell’assoluto perché si nasce, si cresce e si apprende nella durata. Non si passa alla maggiore età, o ad essere “cittadini” per “salti”.
Ognuno ha bisogno di conquistare progressivamente degli spazi a sua misura, di provare l’esercizio delle libertà in situazioni che può capire, d’imparare ad agire articolando il suo desiderio e le costrizioni, il suo punto di vista e l’interesse generale.
Il primo dispositivo che proponiamo è l’assemblea di classe detto anche consiglio di cooperazione, che non è il semplice mettersi in cerchio e parlare di un problema, ma una tecnica ben codificata e sperimentata. Si tratta di un momento periodico nel quale i ragazzi hanno diritto di proposta e critica, un luogo realmente decisionale che interagisce direttamente con la vita della classe.
Se vuoi capire come poter attuare l’assemblea di classe nella tua scuola e se vuoi conoscere altri dispositivi di democrazia vai nella sezione Moodle al seguente link: DEMOCRAZIA
Lì troverai una prima sezione con le istruzioni per l’uso: pochi documenti multimediali che ti consentiranno di capire come mettere in pratica la tecnica. A seguire troverai gli approfondimenti, le esperienze e le altre tecniche di costruzione di democrazia scolastica.
Referente: Marta Marchi
e-mail: ricerca@mce-fimem.it
” … mettere al centro della scuola il bambino, liberarlo da ogni paura, dare motivazione e felicità al suo lavoro, creare intorno a lui dei compagni che non gli siano antagonisti, dare importanza alla sua vita e ai sentimenti più alti che dentro gli si svilupperanno, questo il dovere del maestro, della scuola, di una buona società” (Mario Lodi, Il paese sbagliato)
“Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere la curiosità, riconoscere ed intervenire nelle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo).
I bambini arrivano a scuola con un proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze, spinti da una grande curiosità verso il sapere, interessati a scoprire il mondo che si dischiude piano piano davanti a loro; tutti fattori che, se presi in considerazione dall’adulto, li avviano all’osservazione, alla memoria e al pensiero. Più avanti nei gradi scolastici, i ragazzi mantengono tale inclinazione soprattutto se la scuola non ne ha mortificato l’energia e le propensioni. Essi continuano ad esplorare, in maniera autonoma e spesso con grandi competenze, il mondo nel quale sono immersi.
MCE propone e sostiene un approccio alla conoscenza in cui bambini e ragazzi siano ricercatori attivi e protagonisti del processo di costruzione, di rielaborazione e di produzione della conoscenza. L’insegnante, in una prospettiva progettuale, si fa interprete dei bisogni d’apprendimento, cogliendo i loro interessi e facilitando lo sviluppo dei percorsi. Il sapere, oggetto di conoscenza, è concepito come processo, come svolgimento, come conquista e non come fatto e dato.
Comunicare in madre lingua, sviluppare il pensiero critico e creativo, essere in grado di ricercare e selezionare informazioni, di elaborarle in modo collaborativo e cooperativo, sono azioni che hanno necessità di un ambiente completamente innovato per essere attivate. Questo ordine di obiettivi ha per forza di cose necessità di una pluralità di strumenti, di spazi e di metodi che non possono ridursi e rivolgersi ai libri di testo, già predisposti ed elaborati a monte dagli adulti e comunemente utilizzati quale fonte primaria con valenza sia informativa che formativa.
Nella scuola italiana vi è una possibilità, quella di fare Adozione di strumenti alternativi, conosciuta dai più come Adozione alternativa.
Tale scelta offre più d’una opportunità: rende concreta la libertà di insegnamento garantita dall’art.33 della Costituzione, permette di trovare gli strumenti adatti per la progettazione didattica-educativa di quella specifica classe o scuola; consente di mettere in campo metodologie che rispondano alle necessità reali dei bambini e dei ragazzi, considerati per le loro plurime identità personali, sociali, culturali ed economiche.
Nella complessità e vastità dei saperi, proposti oggi anche su supporti diversificati, fare questa scelta significa lasciare ampio spazio alla costruzione del pensiero poliedrico dei bambini, stupirsi delle loro scoperte, creare un ambiente fatto di parole e di ascolto nel quale tutti possano sentirsi
accolti con la loro specifica identità.
Nelle sedi opportune i docenti, nell’elaborare la richiesta di adozione di strumenti alternativi, possono individuare libri originali e opere artistiche di diverso genere e formato, materiali audiovisivi e artefatti culturali utilizzabili nelle diverse discipline.
Adozione alternativa non significa “opporsi a”, ma fare una scelta all’interno di un quadro legislativo che lo prevede.
Infine, fare questa scelta, lungi dal disperdere testi e risorse, aggiunge valore al nostro Stato poiché conserva, organizza e mette a disposizione di tutti un patrimonio fatto di libri, di risorse multiple, di didattiche innovative e cooperative nello spazio vitale che è la biblioteca di classe e di scuola.
“La mia proposta consiste nel sostituire ai 3, 5 o 10 libri-riassunto, così spesso indigesti, come d’altronde qualsiasi riassunto, una tecnica di lavoro dove il ragazzo tragga il proprio sapere da migliaia di libri, da schede, da dischi, da nastri registrati, per non parlare del grande libro della natura e dell’ambiente sociale a cui attingiamo in fin dei conti le nostre più profonde ricchezze”. (C. Freinet, La scuola del fare)
VADEMECUM ADOZIONE ALTERNATIVA
LETTERA AI DIRIGENTI E AI COLLEGI DOCENTI
Vai nella sezione Moodle al seguente link: RICERCA

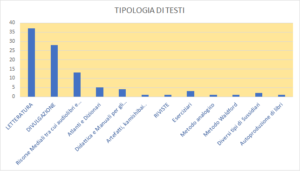

Referente: Giancarlo Cavinato – Roberta Passoni
e-mail: classiaperte@mce-fimem.it
Perché proponiamo come terzo passo l’apertura delle classi costruendo momenti periodici di laboratorio didattico?
Compito della scuola è costruire le condizioni perché la comprensione e l’interpretazione della realtà da soggettive si trasformino in condivise e intersoggettive. Il mondo sociale, scrive Bruner, si costruisce, ricostruisce, interpreta con modalità narrative.
Di qui l’importanza di un contesto organizzato: un’aula progettata e predisposta con cura costituisce un ambiente favorevole ad obiettivi cognitivi e sociali, è il modo che offriamo al corpo e alla mente dei bambini per agire, pensare, dare significato, progettare, anticipare lo sviluppo delle situazioni e coordinare le proprie azioni con quelle degli altri.
Ma l’organizzazione del contesto è una precondizione; narrare e narrarsi, co-costruire significati, ampliare i propri modelli interpretativi non può realizzarsi in gruppi chiusi, in cui si condividono tutte le stesse esperienze e attività.
L’organizzazione di gruppi mobili, eterogenei, con indicazioni di lavoro diversificate, crea una mobilità, un’aspettativa, un desiderio di integrare le proprie ricerche con quelle degli altri.
Il primo dispositivo che proponiamo per rendere operative questo passo è la didattica per laboratori, ‘una mente collettiva’ a cui ognuno partecipa, apporta idee, rappresentazioni mentali, ipotesi, tentativi, ed elabora attraverso le proprie specificità e intelligenze.
Se vuoi capire come poter attuare la didattica per laboratori e se vuoi conoscere altre proposte di didattica attiva vai nella sezione moodle al seguente link: CLASSI APERTE
Lì troverai una prima sezione con le istruzioni per l’uso: pochi documenti multimediali che ti consentiranno di capire come mettere in pratica la tecnica. A seguire troverai gli approfondimenti, le esperienze e le altre tecniche di costruzione di laboratorio didattico.
Referenti: Anna D’Auria – Davide Tamagnini
e-mail: valutazione@mce-fimem.it
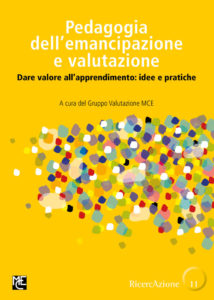 eBook realizzato dal Gruppo Valutazione: Pedagogia dell’emancipazione valutazione
eBook realizzato dal Gruppo Valutazione: Pedagogia dell’emancipazione valutazione
Dare valore all’apprendimento: idee e pratiche a cura del Gruppo Valutazione MCE.
pp. 236, illustrato, ebook € 5,99
Come quarto passo, rifiutiamo una valutazione sommativa fatta di voti numerici, a favore di una valutazione formativa che metta in evidenza punti di forza e di debolezza di ognuno. Perché?
Il bisogno di un pensiero pedagogico forte impone la costruzione di un piano di coerenza fra le pratiche e le forme di valutazione. Un uso politico della professionalità docente, come singolo e come collegio, significa allora che l’operare per la rimozione degli ostacoli deve potersi tradurre in una prassi della valutazione formativa, pensata non come momento esclusivamente finale del processo di insegnamento-apprendimento, ma come pratica di controllo, riflessione, ridefinizione dei processi, individuali e di gruppo, per poterne orientare lo sviluppo successivo.
Per questo la valutazione è uno degli aspetti del fare scuola che ci preoccupa di più, perché è lo “spazio” in cui maggiormente si consolida la dialettica tra normalizzazione ed emancipazione dei soggetti.
Il primo dispositivo che proponiamo è l’abolizione del voto numerico in corso d’anno e l’utilizzo di una valutazione (e autovalutazione) formativa che possa essere motore di miglioramento del singolo e del gruppo.
Se vuoi capire come poter passare ad una didattica formativa e come sperimentare forme di abolizione del voto numerico finale vai nella sezione Moodle al seguente link: VALUTAZIONE
Lì troverai una prima sezione con le istruzioni per l’uso: pochi documenti multimediali che ti consentiranno di capire come mettere in pratica la tecnica. A seguire troverai gli approfondimenti, le esperienze e le altre tecniche di costruzione di valutazione formativa.
© 2024 All rights reserved